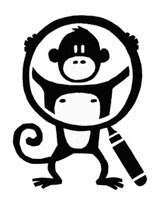- Ciao! - disse mentendo.
(Anonimo)
29 gennaio 2009
28 gennaio 2009
Roberto Bolaño 2666- I, Adelphi, pp 433, euro 19,00 Roberto Bolaño 2666 - II, Adelphi, pp. 672, euro 22,00


Compito ingrato, se non impossibile, accingersi a scrivere una recensione di 2666, e non solo per la difficoltà di tracciarne un esaustivo riassunto ma soprattutto per la consapevolezza che per lungo tempo non riuscirò a trovare qualcosa di più bello, emozionante e commovente. E potrei continuare, anzi è proprio questo il rischio: far sfilare aggettivi a piacimento nella vana speranza di rendere la grandezza di questo autore; autore totale come la sua opera. Certo i miei occhi sono inebriati, innamorati e ancora stanchi della fagocitante lettura, mentre forse la penna richiederebbe freddezza. Eppure, riponendo il volume (o i due volumi) nello scaffale della libreria (se non amate gli altarini), ci si commuove di sé, spiazzati come davanti alla morte. Morte che tristemente coincide con quella di Roberto Bolaño, scomparso nel 2003, poco dopo aver concluso il romanzo, aspettando un trapianto di fegato.
Romanzo totale, perché se si può accennare alla struttura, non è utile incastonare 2666 in alcun genere; almeno non in uno solo.
Romanzo d’avventura, verrebbe da dire per semplificare - cosa certo non amata dall’autore- ma come non trovare nelle 1100 pagine di questa sconfinata avventura, senza cedere un passo di fronte al lirismo poetico che ne accompagna ogni singolo paragrafo, il romanzo di formazione, d’amore, psicologico, il noir, l’hard boiled fino alla più fredda cronaca. Del resto, ci sarebbe il materiale non solamente per 1000 pagine ma per 10.000, se non si affrontasse il rischio d’incorrere in accuse di alto tradimento. Tante, tantissime storie, alcune appena pennellate, tracciate sembra, per puro e personalissimo piacere narrativo; altre che meritano decine di pagine. In più interventi Bolaño ha detto di pensare alla letteratura come una cosa autonoma, capace di nascere e proseguire il suo cammino in maniera autosufficiente, forse per questo l’autore pur capace di forgiarne di preziosissime, non ha mai intenzionalmente fornito ai suoi scritti delle sicure stampelle come possono essere i generi, se non è dunque utile analizzarli, può esserlo almeno sottolineare il tema ricorrente dei romanzi dello scrittore cileno. In 2666 come nei Detective Selvaggi, il motore, il cuore narrativo è la ricerca (sempre uno scrittore scomparso), tema che nell’autore sembra assurgere a un compito divino, un esercizio salvifico del proprio vivere. Un’indagine costruita attraverso un’infinità di voci che amano perdersi per poi ritrovarsi quando ormai non te lo aspetti, alcune apparentemente capziose ma egualmente capaci di tracciare personaggi grandi e minori, tutti utili alla causa. Questo è il cosmo di Roberto Bolaño.
Rodrigo Fresán (Esperanto; I giardini di Kensington) scrittore amico dell’autore cercando di riassumere le sue impressioni sulla lettura di 2666, ha presto abbandonato l’impresa riuscendo a scrivere solamente: «Niente da dire. Difficile scrivere qualcosa su tutto».
Il tutto prende forma dall’Europa a Santa Teresa, città di confine nel deserto di Sonora. Il libro comincia, infatti, con l’amicizia di quattro critici di diverse nazionalità (francese, inglese, italiana, spagnola), legati da una stessa passione-ossessione per il misterioso scrittore Benno von Arcimboldi. Tre di loro seguiranno le tracce dello scrittore fino in Messico, a far loro da guida (siamo già nella seconda parte) il professore cileno Amalfitano, che dopo essere sfuggito alla dittatura di Pinochet e aver girato il mondo, si stabilizza a Santa Teresa, nome che cela la vera Ciudad Juàrez, con sua figlia Rosa. Insieme alla ragazza andremo alla scoperta di Oscar Fate, antieroe per eccellenza e redattore sportivo di colore chiamato in Messico per seguire un incontro di boxe (terza parte). Dopo un anno d’attesa escono sempre per i tipi dell’ Adelphi le ultime due parti. La parte dei delitti, delle efferatezze raccontate con diagnostica freddezza e al contempo con quel lirismo che l’accomuna in parte alla poetica di Edgar Lee Master, infatti, dietro a un catalogo di esemplari umani e vite diverse si cela un’ unica matrice che ci racconta vite disperate e terribilmente concluse. Quella dei delitti è la parte più lenta, una pausa nera di terrore che Bolaño concede e si concede prima dell’epilogo: La parte di Arcimboldi. La ricerca sembra conclusa, il lettore verrà a sapere qualcosa in più della misteriosa vita dello scrittore tedesco, della sua famiglia, dell’amore per la sorellina e della metamorfosi che l’ha trascinato fino al deserto di Sonora. Eppure non ci basta, vorremmo sapere di più, vorremmo sapere tutto, se Roberto Bolaño è Benno Von Arcimboldi oppure Amalfitano o se solamente nel detective selvaggio Arturo Belano possiamo ritrovarlo, vorremmo sapere Roberto Bolaño ancora vivo, magari perso nei suoi deserti, vorremmo ci regalasse ancora tante pagine e magari, vedere edite anche in Italia le sue poesie.
Romanzo totale, perché se si può accennare alla struttura, non è utile incastonare 2666 in alcun genere; almeno non in uno solo.
Romanzo d’avventura, verrebbe da dire per semplificare - cosa certo non amata dall’autore- ma come non trovare nelle 1100 pagine di questa sconfinata avventura, senza cedere un passo di fronte al lirismo poetico che ne accompagna ogni singolo paragrafo, il romanzo di formazione, d’amore, psicologico, il noir, l’hard boiled fino alla più fredda cronaca. Del resto, ci sarebbe il materiale non solamente per 1000 pagine ma per 10.000, se non si affrontasse il rischio d’incorrere in accuse di alto tradimento. Tante, tantissime storie, alcune appena pennellate, tracciate sembra, per puro e personalissimo piacere narrativo; altre che meritano decine di pagine. In più interventi Bolaño ha detto di pensare alla letteratura come una cosa autonoma, capace di nascere e proseguire il suo cammino in maniera autosufficiente, forse per questo l’autore pur capace di forgiarne di preziosissime, non ha mai intenzionalmente fornito ai suoi scritti delle sicure stampelle come possono essere i generi, se non è dunque utile analizzarli, può esserlo almeno sottolineare il tema ricorrente dei romanzi dello scrittore cileno. In 2666 come nei Detective Selvaggi, il motore, il cuore narrativo è la ricerca (sempre uno scrittore scomparso), tema che nell’autore sembra assurgere a un compito divino, un esercizio salvifico del proprio vivere. Un’indagine costruita attraverso un’infinità di voci che amano perdersi per poi ritrovarsi quando ormai non te lo aspetti, alcune apparentemente capziose ma egualmente capaci di tracciare personaggi grandi e minori, tutti utili alla causa. Questo è il cosmo di Roberto Bolaño.
Rodrigo Fresán (Esperanto; I giardini di Kensington) scrittore amico dell’autore cercando di riassumere le sue impressioni sulla lettura di 2666, ha presto abbandonato l’impresa riuscendo a scrivere solamente: «Niente da dire. Difficile scrivere qualcosa su tutto».
Il tutto prende forma dall’Europa a Santa Teresa, città di confine nel deserto di Sonora. Il libro comincia, infatti, con l’amicizia di quattro critici di diverse nazionalità (francese, inglese, italiana, spagnola), legati da una stessa passione-ossessione per il misterioso scrittore Benno von Arcimboldi. Tre di loro seguiranno le tracce dello scrittore fino in Messico, a far loro da guida (siamo già nella seconda parte) il professore cileno Amalfitano, che dopo essere sfuggito alla dittatura di Pinochet e aver girato il mondo, si stabilizza a Santa Teresa, nome che cela la vera Ciudad Juàrez, con sua figlia Rosa. Insieme alla ragazza andremo alla scoperta di Oscar Fate, antieroe per eccellenza e redattore sportivo di colore chiamato in Messico per seguire un incontro di boxe (terza parte). Dopo un anno d’attesa escono sempre per i tipi dell’ Adelphi le ultime due parti. La parte dei delitti, delle efferatezze raccontate con diagnostica freddezza e al contempo con quel lirismo che l’accomuna in parte alla poetica di Edgar Lee Master, infatti, dietro a un catalogo di esemplari umani e vite diverse si cela un’ unica matrice che ci racconta vite disperate e terribilmente concluse. Quella dei delitti è la parte più lenta, una pausa nera di terrore che Bolaño concede e si concede prima dell’epilogo: La parte di Arcimboldi. La ricerca sembra conclusa, il lettore verrà a sapere qualcosa in più della misteriosa vita dello scrittore tedesco, della sua famiglia, dell’amore per la sorellina e della metamorfosi che l’ha trascinato fino al deserto di Sonora. Eppure non ci basta, vorremmo sapere di più, vorremmo sapere tutto, se Roberto Bolaño è Benno Von Arcimboldi oppure Amalfitano o se solamente nel detective selvaggio Arturo Belano possiamo ritrovarlo, vorremmo sapere Roberto Bolaño ancora vivo, magari perso nei suoi deserti, vorremmo ci regalasse ancora tante pagine e magari, vedere edite anche in Italia le sue poesie.
Massimiliano Di Mino
27 gennaio 2009
Giacomo Leopardi, Memorie del primo amore, Adelphi, pp.62, euro 5,50
 Sarò volgare io ma certe volte mi parrebbe meglio, piuttosto che stare tanto a pensare alla felicità, dico individuale come dei popoli; sarebbe meglio pensare a vivere: io, per esempio, preferisco vivere.
Sarò volgare io ma certe volte mi parrebbe meglio, piuttosto che stare tanto a pensare alla felicità, dico individuale come dei popoli; sarebbe meglio pensare a vivere: io, per esempio, preferisco vivere.Voglio fare un esempio: in questo ultimo anno di capitalismo avanzato è andato molto di moda (moda, ma menstrua beltà dice meglio il Giacomo in persona) questo Donne che amano troppo di Robin Norwood che è un libro che parla di donne che amano troppo gli uomini e che, cioè, esclude dai suoi interessi le donne che amano troppo le donne, qualsiasi cosa possa amare un uomo e, nella sua interessata micragna, l’umanità in genere.
Infatti l’interesse, ben ripagato in termini commerciali, della strizzacervelli americana è quello di trattare il dolore di amore come una dipendenza dal quale liberarsi per essere felici: la Norwood ha una ricca esperienza, infatti, come terapeuta, avendo lavorato per oltre dieci anni in quei famigerati centri statunitensi dove si combatte l’alcolismo e l’assuefazione alle droghe: centri infallibili che, per fare un esempio importante, hanno guarito uno sballatone come George Bush rendendolo in grado di dichiarare guerra a mezzo mondo e distruggere, oltre le vite di molti essere umani, le più importanti testimonianze della nostra civiltà devastando la terra dove essa è stata fondata.
Non è un caso: la civiltà nel suo senso più esigente è cultura; la cultura è anima: come dichiara la stessa Norwood la cura alla sofferenza e dipendenza d’amore come dai tossici (e perché non dire chiaramente dalla vita stessa?) è la rinuncia ascetica a questo mondo; la via spirituale: la sconfitta di quel vecchio diavolo perverso e polimorfo, quel bambino che ama chi può quando può, che è l’anima (anima, diceva a un dipresso il santo Paolo, dove è il tuo pungiglione?): le donne amino gli uomini, gli uomini amino le donne: poco e con discrezione (solo per dio, c’era scritto sui mutandoni delle nonne).
E se uno, invece, gli piacesse più vivere che essere felice?
Ecco che qualcuno ti ristampa Memorie del primo amore, un diario che Giacomo Leopardi, divenuto un classico giusto in tempo perché nessun giovane lo legga se non nel tedio ed odio dell’ora scolastica, ha scritto quasi ventenne. Bisogna calcolare che a ventuno anni Leopardi si reputava, e non a torto, decrepito, e che il giovane, dalla frequentazione di una tale decrepito, di una tale saggezza sdegnosa del ridicolo progressivo e magnifico della nostra sorte di moderni, ne potrebbe uscire con quel tanto di pericoloso che non piace alla gente che piace.
Cosa faceva a vent’anni Giacomo Leopardi per divenire tanto pericoloso? Incontrava tale parente Geltrude Cassi Lazzari di cui si innamorava nel modo e nella maniera in cui si dice nell’elegia Il primo amore e, segnatamente, secondo una scrupolosa strategia sentimentale come è dettagliata in queste pagine di diario.
Il testo è più chiaro di un manuale: per amare, cioè vivere, bisogna essere disponibili all’impresa: Io cominciando a sentire l’impero della bellezza, da più d’un anno desiderava di parlare e conversare, come tutti fanno, con donne avvenenti. Prima la soggezione all’amore e alla bellezza, l’invasamento: e solo poi un oggetto qualsiasi: tanto qualsiasi che, in effetti, la Geltrude pare a Giacomo, alta e membruta quanto nessuna donna ch’io abbia veduta mai, di volto però tutt’altro che grossolano. Non bella, certo: a malapena l’oggetto che, unico o passabile, gli si prestava pronto alla sua esigenza di essere dominato dall’amore. E voi direte: ma perché voleva esserne così tanto e a tutti costi soggetto a detto sentimento? È ovvio: voleva avere a che fare con il suo caro dolore.
E va bene, non sarebbe facile ridurre a burletta o a caso clinico questo avere a caro il dolore?
Tutto è facile, fuorché vivere: non so come sia stato come poeta, ebbe, non proprio parola per parola, a dire il leopardiano Ungaretti, ma come uomo ho sofferto, ho vissuto. L’Ungaretti che amava lo stacco di coscia. E in bella compagnia: l’Apuleio che, in preda alle enormi passioni asinine, ha penato, penato prima di sciogliere, e riconoscersi, nel dolore davanti a quella Luna, regina del cielo, o alma Cerere, antichissima madre delle messi, dea dai tanti nomi e dai tanti e qualsiasi aspetti, pure quello della membruta e sgraziata Geltrude,e dell’uomo e della donna che amiamo.
Dea dai tanti nomi questa occasione di patimento, di ossessione, di dipendenza, di perversa e polimorfa vita: una vita per cui vale la pena di vivere.
Pier Paolo Di Mino
H.G.Wells, Nel paese dei ciechi, Adelphi, pp. 60, euro 5,50
 Non si può fare a meno di scrivere e riscrivere, a parole o fatti, questa eterna storia (così umana nella sua aspirazione ad andare oltre l’umano) di diventare re: the man who would be king; ma ancora l’imbroglione Orélie che si consacra imperatore di Patagonia; Sertorio che si fa adorare come un re divino dai suoi celtiberi; Arnoldo di Brescia e la sua repubblica santa; Kurtz, ovvio: e D’annunzio.
Non si può fare a meno di scrivere e riscrivere, a parole o fatti, questa eterna storia (così umana nella sua aspirazione ad andare oltre l’umano) di diventare re: the man who would be king; ma ancora l’imbroglione Orélie che si consacra imperatore di Patagonia; Sertorio che si fa adorare come un re divino dai suoi celtiberi; Arnoldo di Brescia e la sua repubblica santa; Kurtz, ovvio: e D’annunzio.Il n’ya de nouveau que ce qui est oublié, ci avverte la marchande de modes della buona Maria Antonietta, Madame Bertin.
È questa storia di uomini che diventano re è, infatti, sempre nuova, così eterna e umana, perché è così eterno e umano il bisogno di dimenticare questo istinto basilare al massacro e al dominio, o alla conversione; questa piega, così facile a prendersi, a ritrovare in sé il troppo di animale, o il troppo di divino.
Potremmo rileggerla, questa storia, mille volte di seguito, in una qualsiasi delle sue versioni senza mancare di provare ogni volta il medesimo incantato ribrezzo, la coscienza sapientemente annebbiata di appartenere a questo orrore (The horror!, the horror!), la stessa esaltata noia e gioia e, poi, la medesima, identica necessità di dimenticare e di tornare al nostro mondo dove (fa dire ad Àlvar Nùñez Cabeza de Vaca il prezioso Haniel Long) “la gente vive in case di pietra, coltiva gli stessi campi un anno dopo l’altro, costruisce granai per stivare messi. ”
Nella parabola di Long questo Nùñez Cabeza de Vaca decide di rifiutare recisamente il mondo così come pare che sia, convinto che la vita collettiva prosciughi il nostro latte; che la collettività ci dia l’illusione fatale di poterci esonerare dalle nostre personali responsabilità nei confronti dell’altro; e che una vita che si chiami vita è solo quella che lui ha vissuto in mezzo agli indios curandoli in virtù dei ritrovati poteri che il vecchio mondo gli aveva disseccato: votandosi insomma ad una particolare regalità, quella del santo.
Sia detto non per caso che in questa storia, volere sottomettere o salvare un popolo, è cosa del tutto indifferente: il punto non è farsi riconoscere come un dio o come un animale, ma farsi riconoscere. Farsi investire, dall’altro, della regalità.
Come in un sogno, certe opportune e garbate distinzioni non si danno. E se la nostra Storia è un incubo, direbbe Joyce, questa storia è, invece, il sogno.
E, come tale, sembra che abbia voluta riproporcela anche H.G. Wells in questo ipnotico e spaventoso Nel paese dei ciechi dove, sarà sicuramente un caso, un tale Nùñez, in Sudamerica, finisce, in seguito ad un incidente d’alta montagna, in un perduto e leggendario villaggio di ciechi: un villaggio di vecchissimi colonizzatori, isolato in una vallata, e colpito da una maledizione che ha reso i suoi abitanti geneticamente ciechi. I ciechi in questione, dopo generazioni, si sono perfino scordati della vista, e la loro filosofia, la loro religione, la loro vita pratica e sentimentale esclude il concetto stesso di visione: il che li rende sufficientemente altro da noi da istigare in chicchessia la feroce volontà di dominarli o liberarli.
Il nostro Nùñez, fidando sul luogo comune secondo il quale l’orbo in una terra di ciechi è re, decide, insomma, di dominarli. In fondo non dovrà fare altro che dimostrare la propria superiorità esibendo una facoltà come la vista; che, però, secondo ogni evidenza dei ciechi è anche una facoltà del tutto non esistente, frutto di una mente primitiva, malata, e blasfema: morale, Nùñez viene impiegato per lavori pesanti e servili, finché, come liberandosi da un sogno, non fugge, risale le montagne e non ritorna a vedere le stelle qui del nostro mondo.
Questa è l’unica vera differenza possibile, quello fra l’incubo piatto e grigio della nostra Storia fatta da gente che vive in case di pietra, coltiva gli stessi campi un anno dopo l’altro, costruisce granai per stivare messi, e questo sogno esaltato e orribile in cui un uomo, a contatto con l’altro (con l’inferno che è l’altro), si scopre bestia o dio; scopre il proprio diritto a comandare e scopre che questo diritto glielo può solo comandare un altro: che essere re è servire come un animale da soma; è pulire le piaghe malate del prossimo tuo.
E non c’è re che nella terra dei ciechi, al cui altare senza immagini, alla fine, dobbiamo tutti versare il nostro sacrificio.
Pier Paolo Di Mino
Iscriviti a:
Post (Atom)