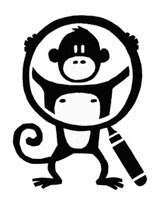Non si può fare a meno di scrivere e riscrivere, a parole o fatti, questa eterna storia (così umana nella sua aspirazione ad andare oltre l’umano) di diventare re: the man who would be king; ma ancora l’imbroglione Orélie che si consacra imperatore di Patagonia; Sertorio che si fa adorare come un re divino dai suoi celtiberi; Arnoldo di Brescia e la sua repubblica santa; Kurtz, ovvio: e D’annunzio.
Non si può fare a meno di scrivere e riscrivere, a parole o fatti, questa eterna storia (così umana nella sua aspirazione ad andare oltre l’umano) di diventare re: the man who would be king; ma ancora l’imbroglione Orélie che si consacra imperatore di Patagonia; Sertorio che si fa adorare come un re divino dai suoi celtiberi; Arnoldo di Brescia e la sua repubblica santa; Kurtz, ovvio: e D’annunzio.Il n’ya de nouveau que ce qui est oublié, ci avverte la marchande de modes della buona Maria Antonietta, Madame Bertin.
È questa storia di uomini che diventano re è, infatti, sempre nuova, così eterna e umana, perché è così eterno e umano il bisogno di dimenticare questo istinto basilare al massacro e al dominio, o alla conversione; questa piega, così facile a prendersi, a ritrovare in sé il troppo di animale, o il troppo di divino.
Potremmo rileggerla, questa storia, mille volte di seguito, in una qualsiasi delle sue versioni senza mancare di provare ogni volta il medesimo incantato ribrezzo, la coscienza sapientemente annebbiata di appartenere a questo orrore (The horror!, the horror!), la stessa esaltata noia e gioia e, poi, la medesima, identica necessità di dimenticare e di tornare al nostro mondo dove (fa dire ad Àlvar Nùñez Cabeza de Vaca il prezioso Haniel Long) “la gente vive in case di pietra, coltiva gli stessi campi un anno dopo l’altro, costruisce granai per stivare messi. ”
Nella parabola di Long questo Nùñez Cabeza de Vaca decide di rifiutare recisamente il mondo così come pare che sia, convinto che la vita collettiva prosciughi il nostro latte; che la collettività ci dia l’illusione fatale di poterci esonerare dalle nostre personali responsabilità nei confronti dell’altro; e che una vita che si chiami vita è solo quella che lui ha vissuto in mezzo agli indios curandoli in virtù dei ritrovati poteri che il vecchio mondo gli aveva disseccato: votandosi insomma ad una particolare regalità, quella del santo.
Sia detto non per caso che in questa storia, volere sottomettere o salvare un popolo, è cosa del tutto indifferente: il punto non è farsi riconoscere come un dio o come un animale, ma farsi riconoscere. Farsi investire, dall’altro, della regalità.
Come in un sogno, certe opportune e garbate distinzioni non si danno. E se la nostra Storia è un incubo, direbbe Joyce, questa storia è, invece, il sogno.
E, come tale, sembra che abbia voluta riproporcela anche H.G. Wells in questo ipnotico e spaventoso Nel paese dei ciechi dove, sarà sicuramente un caso, un tale Nùñez, in Sudamerica, finisce, in seguito ad un incidente d’alta montagna, in un perduto e leggendario villaggio di ciechi: un villaggio di vecchissimi colonizzatori, isolato in una vallata, e colpito da una maledizione che ha reso i suoi abitanti geneticamente ciechi. I ciechi in questione, dopo generazioni, si sono perfino scordati della vista, e la loro filosofia, la loro religione, la loro vita pratica e sentimentale esclude il concetto stesso di visione: il che li rende sufficientemente altro da noi da istigare in chicchessia la feroce volontà di dominarli o liberarli.
Il nostro Nùñez, fidando sul luogo comune secondo il quale l’orbo in una terra di ciechi è re, decide, insomma, di dominarli. In fondo non dovrà fare altro che dimostrare la propria superiorità esibendo una facoltà come la vista; che, però, secondo ogni evidenza dei ciechi è anche una facoltà del tutto non esistente, frutto di una mente primitiva, malata, e blasfema: morale, Nùñez viene impiegato per lavori pesanti e servili, finché, come liberandosi da un sogno, non fugge, risale le montagne e non ritorna a vedere le stelle qui del nostro mondo.
Questa è l’unica vera differenza possibile, quello fra l’incubo piatto e grigio della nostra Storia fatta da gente che vive in case di pietra, coltiva gli stessi campi un anno dopo l’altro, costruisce granai per stivare messi, e questo sogno esaltato e orribile in cui un uomo, a contatto con l’altro (con l’inferno che è l’altro), si scopre bestia o dio; scopre il proprio diritto a comandare e scopre che questo diritto glielo può solo comandare un altro: che essere re è servire come un animale da soma; è pulire le piaghe malate del prossimo tuo.
E non c’è re che nella terra dei ciechi, al cui altare senza immagini, alla fine, dobbiamo tutti versare il nostro sacrificio.
Pier Paolo Di Mino